Come si risolve una lussazione della spalla?
Evento frequente negli sport da contatto, la lussazione della spalla porta a instabilità articolare e a possibili recidive.
Il trattamento chirurgico è quasi sempre risolutivo, ma da valutare in relazione alle effettive esigenze funzionali del paziente. Il percorso riabilitativo gioca un ruolo chiave nel completo recupero della funzionalità articolare.
Negli sport di contatto e di collisione, nel rugby, o nel football americano o, ancora, in sport di lancio come il tennis, la lussazione della spalla è un evento traumatico frequente.
Si tratta della classica dislocazione con l’uscita della testa dell’omero dalla cavità glenoidea della scapola che provoca nell’atleta una sensazione di forte dolore.
L’obiettivo primario, a seguito di una lussazione di spalla, è quello di riportare, dopo conferma radiografica, in sede la testa dell’omero attraverso un’opportuna manovra di riduzione effettuata sotto sedazione. Se, a seguito di un primo episodio di lussazione, la terapia conservativa rappresenta il trattamento gold standard, la letteratura scientifica evidenzia, d’altro canto, un elevato rischio di recidiva in atleti agonisti che praticano sport a rischio.
In questi soggetti, pertanto, dovrà essere valutato il trattamento chirurgico già a seguito del primo episodio di lussazione, trattamento che consentirà, nella quasi totalità dei casi, il pieno recupero della funzione articolare evitando possibili recidive.
La riabilitazione rappresenta una fase delicata del percorso terapeutico. Deve essere condotta da un fisioterapista esperto al fine di garantire sia la ripresa della piena funzionalità articolare, sia il rispetto del timing concordato con il team sportivo.
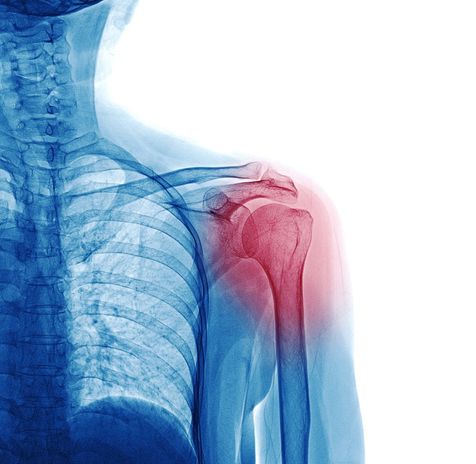
Che cosa si intende per lussazione di spalla?
Fulcro essenziale nella catena cinetica impegnata nel sollevamento del braccio, nella sua rotazione e nell’innalzamento oltre il capo, la spalla è l’articolazione più mobile del corpo. Si tratta di un fine equilibrio muscolo-tendineo-legamentoso che, se disturbato, può causare instabilità e portare al fenomeno della lussazione, un evento frequente nei rugbisti, nei giocatori di football americano e in quegli sport in genere di contatto o di collisione.
La lussazione di spalla, quindi l’uscita della testa dell’omero dalla cavità glenoidea della scapola avviene comunemente a seguito di una caduta su un braccio disteso e con spalla abdotta e ruotata esternamente.
Quando la testa dell'omero si disloca, la superficie della glena e i legamenti della spalla sono interessati e lesionati. Il labrum o cercine glenoideo – il bordo della cartilagine che circonda i margini della glena – si distacca dal tessuto osseo. Parliamo, in questo caso, di “lesione di Bankart” mentre, se questo legamento rimane inserito in un frammento osseo, si parla di “Bony Bankart”.
Cosa comporta una lussazione alla spalla?
La lussazione di spalla provoca forte dolore. L’infortunato dovrebbe essere sottoposto, il più presto possibile, a cure mediche, ad una radiografia che confermi la lussazione ed alla successiva manovra di riduzione – per ricentrare la testa dell’omero nella cavità glenoidea – effettuata da personale esperto sotto sedazione al fine di attenuare la sintomatologia algica e favorire, così, il rilassamento muscolare.
Come si guarisce?
In caso di primo episodio di lussazione, il trattamento classico è di tipo conservativo. Il braccio viene immobilizzato con un tutore in rotazione neutra o in extra-rotazione lieve per 20-25 giorni. Seguiranno una visita di controllo ed il trattamento riabilitativo.
L’obiettivo sarà quello di un riequilibrio della postura, del rinforzo del muscolo scapolo-toracico ed un cauto e progressivo recupero dell’articolarità prima passivo poi attivo, sempre, comunque, rispettando la soglia del dolore. Il distacco del cercine glenoideo determina una riduzione della tensione legamentosa e una conseguente instabilità articolare che può essere foriera di ulteriori episodi di lussazione.
È importante precisare che le recidive sono più frequenti nelle classi a rischio come il giovane maschio che fa attività sportiva di contatto, di collisione, dove la probabilità di una nuova lussazione nei mesi successivi al rientro in campo sale all’80%. Diverso è, invece, il caso del soggetto che non pratica attività sportiva a livello agonistico, ma che conduce una vita normale.
Le probabilità di recidiva sono molto basse anche se il rischio è presente praticando attività sportive a rischio come il nuoto a dorso, i tuffi ecc. Il trattamento conservativo impone, comunque, il ridimensionamento del proprio stile di vita evitando quelle attività che possano aggravare i sintomi fino al verificarsi di una nuova lussazione.
La chirurgia
Nel caso di una prima lussazione, l'indicazione chirurgica è quindi paziente specifica, mentre rappresenta sempre il trattamento consigliato nel caso di recidive. Quando le lussazioni diventano recidivanti o in casi selezionati dopo il primo episodio, il trattamento chirurgico è la via d’elezione. Oggi possiamo considerare due tecniche operatorie principali:
- la tecnica artroscopica (ricostruzione di Bankart);
- la Latarjet.
La ricostruzione di Bankart ha l’obiettivo di reinserire il tessuto legamentoso nel tessuto osseo tramite ancorette, così da ricostruire l’amaca inferiore che garantisce la stabilità. L’intervento di “Plastica secondo Latarjet” è, invece, utilizzato nelle instabilità antero-inferiori recidivanti di spalla se presentano deficit ossei importanti sulla testa omerale (Lesione di Hill-Sachs) e/o perdite ossee sulla regione anteriore della glena. L’obiettivo di tale tecnica è di stabilizzare l’articolazione della spalla attraverso la compensazione della lesione capsulo-legamentosa e ossea, mediante una contenzione ossea e dei tessuti molli, in modo tale da bloccare l'eccessiva traslazione e ripristinare la stabilità.
La nostra equipe ha messo a punto una modificazione della tecnica di Latarjet, la quale è oggi utilizzata in Italia e all’estero. Essa prevede l’utilizzo della coracoide come bratta ossea da apporre nella regione antero-inferiore della glenoide. Questa, insieme al tendine congiunto, che rimane inserito all'apice della stessa, stabilizza l’articolazione gleno-omerale attraverso tre effetti differenti:
- l’estensione della superficie articolare glenoidea dovuta al posizionamento della bratta ossea;
- l’effetto amaca ottenuto dal passaggio del tendine congiunto a cavallo della porzione inferiore del muscolo sottoscapolare;
- il ritensionamento capsulare, dove possibile;
- la placchetta che, intervenendo sulla biologia e sulla meccanica dell'intervento, migliora i risultati clinici in termini qualitativi e quantitativi.
Cosa fare dopo l’intervento?
A seguito dell'intervento chirurgico, le recidive risultano estremamente ridotte. Il 97-98% dei pazienti a cinque anni non subisce ulteriori lussazioni dovute a traumi importanti. Il percorso riabilitativo rappresenta una fase fondamentale per una ripresa ottimale dell’attività agonistica che solitamente avviene a circa tre mesi dall’intervento.
Stiamo parlando di pazienti complessi, con un calendario di impegni sportivi non prorogabili e con la necessità di riprendere appieno la funzionalità articolare per garantire le migliori performance del gesto atletico. Già dall’immediato post-operatorio il paziente indosserà un tutore. Comune è quello con un supporto in abduzione per una posizione ottimale dell’arto sul piano scapolare a circa 30° di abduzione.
La riabilitazione
Il lavoro con il fisioterapista inizierà a due settimane circa dall’intervento. Il terapista lavorerà anche con cauti massaggi decontratturanti al fine di evitare la formazione di aderenze. Si passa, quindi, ad una kinesi attiva per migliorare il range di movimento.
Generalmente, vi sono poche o nessuna restrizione riguardo la flessione anteriore e l'abduzione sul piano scapolare, così come nella rotazione interna. Sempre nella fase iniziale della riabilitazione potranno essere utilizzati specifici metodi per attivare la muscolatura che stabilizza l’articolazione gleno-omerale e l’articolazione scapolare.
Quando avviene il ritorno in campo per un atleta?
Con la fase intermedia, a 6-8 settimane dall’operazione, inizia il rinforzo muscolare con esercizi specifici. L’atleta progredirà in questa fase fino ai gradi finali del ROM su ogni piano di movimentoIn questa fase riabilitativa, oltre ad aggiungere esercizi più complessi, viene aumentato anche il grado di elevazione dell’omero negli esercizi scapolari e in quelli per la cuffia dei rotatori. La fase successiva di ritorno alla funzionalità si caratterizza per un recupero continuativo del movimento funzionale, così come per l’introduzione di esercizi di maggior difficoltà per la cuffia dei rotatori ed esercizi scapolari focalizzati sul ritorno del paziente al proprio livello funzionale.
I criteri di ritorno allo sport, infine, sono di ordine oggettivo e soggettivo. L’utilizzo di una valutazione oggettiva consente all’equipe di gestire il ritorno degli individui alla funzionalità sulla base di parametri oggettivi (che possono, per questo motivo, essere valutati ed effettuati nuovamente, se necessario, durante le fasi successive della riabilitazione). I criteri soggettivi, invece, riguardano le sensazioni proprie dell’atleta: sente l’articolazione sicura, forte, coordinata; non mostra apprensione.
L’obiettivo dell’intero percorso riabilitativo sarà la reintegrazione dell’anello debole – la spalla operata – all’interno della catena cinetica complessa del gesto atletico nei giusti tempi e modalità.
Bibliografia
- Biggi, Francesco, and Francesco Biggi. "Fratture e lussazioni della spalla." Guida tascabile di traumatologia (2014): 35-50.
- Randelli, M., et al. "Lussazione inveterata posteriore della spalla. Principi di trattamento." LO SCALPELLO-OTODI Educational 2.25 (2011): 154-156.
- Test Fail. "Fisioterapia per la Lussazione della Spalla e gli Esercizi di Riabilitazione."
- Vergano, L. Branca, G. Sartori, and M. Uggeri. "Frattura-lussazione della spalla con dislocazione intratoracica della testa omerale: discussione di un caso." GIOT 34 (2008): 21-24.
- Villani, C., et al. "Capsuloplastica nella lussazione recidivante anteriore di spalla: valutazioni."


