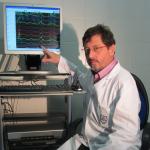Come si diagnostica il reflusso gastroesofageo?
Lo studio della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) si avvale di tre metodiche diagnostiche principali e di alcune secondarie. Le principali sono:
- l’esofago-gastro-duodenoscopia, che valuta il danno mucosale e l’eventuale presenza di un’ernia iatale. Con questa metodica non sempre si fa diagnosi, data l’alta percentuale di malattia da reflusso senza lesioni esofagee (NERD: non erosive reflux disease); pertanto, non giova ripeterla frequentemente (fatta eccezione per lesioni precancerose come nell’esofago di Barrett);
- la pH-impedenziometria esofagea delle 24 ore (MII/pH, multichannel intraluminal impedance and pH monitoring) è attualmente considerata la tecnica più affidabile (gold standard) per evidenziare il reflusso gastroesofageo in quanto consente di riconoscere qualsiasi episodio di reflusso e di definirne: composizione (acida, debolmente acida, basica, neutra), durata, localizzazione e natura (solida, liquida, gassosa, mista).
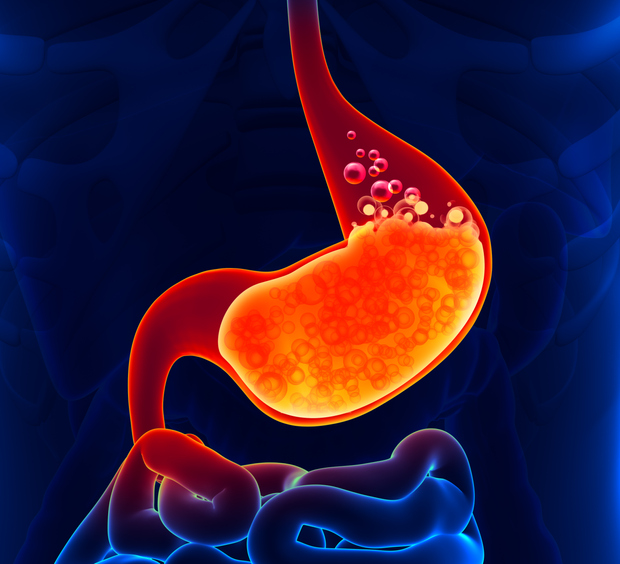
Quest’ultimo esame è un’importante evoluzione della pHmetria esofagea delle 24 ore. La pHmetria aveva, infatti, dei limiti importanti, in quanto identificava come reflusso esofageo di tipo acido esclusivamente ogni caduta del pH al di sotto del valore 4. Generalmente, il reflusso si considera terminato quando il valore di pH risale oltre il valore di 4. Tuttavia, questa tecnica non consentiva di stabilire a che altezza arrivasse il reflusso in esofago; pertanto, pazienti clinicamente sintomatici potevano avere una pH-metria negativa. Queste problematiche sono state superate dalla pH-impedenziometria delle 24 ore.
Come funziona la pH-impedenziometria?
L’esame prevede l’introduzione di un catetere di circa 1mm di diametro per via transnasale (l’esecuzione dura in genere pochi minuti); su di esso è posizionato un sensore di pH (a volte 2) e sei canali che misurano l’impedenza elettrica. Questo deve essere posizionato 5 cm sopra lo sfintere esofageo inferiore (LES) e viene lasciato in sede per 24 ore collegato a un registratore portatile.
Durante l’esecuzione dell’esame, il paziente deve condurre la sua vita abituale (anche andando a lavorare) e segnare sui tasti del registratore orari di pasti, eventuali sintomi, posizione (ortostatismo, clinostatismo).
L’impedenza è l’inverso della conduttività e varia con la natura chimica e fisica del bolo; pertanto, la sua misura sullo strumento consente di visualizzare direzione e transito del bolo, anche se questo è un gas o un reflusso.
Avendo 6 canali di impedenza, lo strumento permette di evidenziare la durata dell’esposizione al reflusso e l’altezza che lo stesso raggiunge nell’esofago, dati fondamentali da un punto di vista clinico e terapeutico.
In sintesi, le misurazioni combinate di pH e impedenza hanno consentito di classificare nuove categorie di reflusso non evidenziabili con la sola pH-metria:
- reflussi acidi (pH < 4, come con l’esame di pHmetria);
- reflussi acidi ripetuti e ravvicinati (pH < 4, normalmente riconosciuti come unico episodio di reflusso con la pHmetria);
- reflussi debolmente acidi (4 < pH < 7);
- reflussi non acidi (pH > 7).
Cos’è la manometria esofagea?
La fisiopatologia del primo tratto dell’apparato digerente comprende lo studio della motilità faringe, dell’esofago e dei suoi sfinteri (Upper Esophageal Sphincter, UES e Lower Esophageal Sphincter, LES).
La manometria esofagea ad alta risoluzione (HRM), sfruttando le sonde di ultima generazione, fornisce la possibilità di dare, contemporaneamente, informazioni immediate di tutto il tratto digestivo superiore. La nuova tecnologia, con la nuova “Classificazione di Chicago”, fornisce una precisione e una facilità di diagnosi mai raggiunta prima.
L’esame di manometria esofagea ad alta risoluzione è svolto attraverso l’introduzione per via transnasale di un catetere con numero di sensori variabile da 24 a 36 a seconda della tecnologia. Ciò permette lo studio completo della fase deglutitoria mantenendo il sondino in un’unica posizione, con il risultato di ottenere:
- risultati completi e coordinati di tutta l’attività deglutitoria e peristaltica;
- maggiore rapidità di esecuzione dell’esame;
- maggiore accettazione dell’esame da parte del paziente.
Sappiamo che la MRGE è una patologia a genesi essenzialmente motoria e, pertanto, legata ad alterazioni funzionali dei meccanismi che abitualmente prevengono il reflusso. Le alterazioni funzionali di più frequente riscontro sono:
- riduzione del tono basale del LES (nei pazienti è quasi sempre inferiore ai 10 mmHg);
- rilasciamenti spontanei transitori del LES;
- ritardato svuotamento gastrico, con conseguente aumento della pressione intragastrica;
- alterazioni della peristalsi esofagea, che determinano una ridotta capacità di rimozione del materiale refluito (generalmente l’ampiezza della contrazione è più o meno ridotta).
Quando l’ampiezza dell’onda contrattile è insufficiente a determinare una chiusura del lume a monte del bolo e c’è una riduzione della pressione del LES, si verifica il reflusso. Inoltre, i pazienti con MRGE presentano una maggior proporzione di contrazioni peristaltiche inefficaci. L’inefficacia della peristalsi può essere frequente, per cui, dopo la deglutizione volontaria, non ha inizio alcuna contrazione. Anche le onde peristaltiche non propagate o simultanee si associano proporzionalmente alla severità della malattia.
Conclusioni
Le tre tecniche diagnostiche di prima scelta nella MRGE sono:
- esame endoscopico: è insostituibile per accertare l’esistenza e la severità dell’esofagite e delle sue complicanze;
- pH-impedenziometria: è il metodo più affidabile per evidenziare la MRGE, in quanto consente di riconoscere qualsiasi episodio di reflusso e di definirne la composizione, durata, localizzazione e il pH;
- manometria esofagea: consente lo studio delle alterazioni funzionali della motilità che sono alla base della prevenzione del reflusso gastroesofageo.
Questo non vuol dire che ogni paziente che presenta dei sintomi episodici e saltuari debba essere sottoposto a pH-impedenziometria delle 24 ore e manometria esofagea HRM. Le indicazioni elettive di queste metodiche complementari tra di loro, infatti, sono:
- studio dei pazienti sintomatici controllati endoscopicamente con esame negativo (NERD);
- studio dei pazienti controllati endoscopicamente con sintomi resistenti alla terapia;
- studio dei pazienti con sintomi atipici o extra-esofagei (quali faringodinia, raucedine, tosse, asma, dolore retrosternale, etc.);
- studio dei pazienti nei quali sia posta l’indicazione al trattamento chirurgico della malattia da reflusso gastroesofageo.
Bibliografia
- Hobbs P, Gyawali CP. The role of esophageal pH-impedance testing in clinical practice. Curr Opin Gastroenterol. 2018 Jul;34(4):249-257.
- Wilkinson JM, Halland M. Esophageal Motility Disorders. Am Fam Physician. 2020 Sep 1;102(5):291-296.