Epidemiologia
Cos’è il tumore dello stomaco?
Il tumore dello stomaco (Carcinoma gastrico) è il secondo tipo di neoplasia più diffuso nel mondo (circa 800.000 nuovi casi e 650.000 decessi per anno; 7,8% di tutte le neoplasie; rapporto maschio:femmina 2:1) con aree ad elevata incidenza rappresentate dall’ Asia, Europa Orientale e Centrale e Sud America. Il tasso di mortalità in Italia è di circa 5-10 casi per 100.000 abitanti.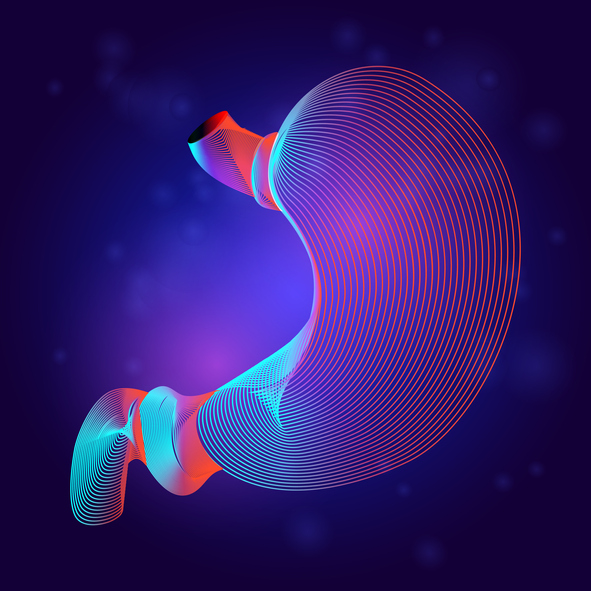
Fattori di rischio
Tumore allo stomaco: chi è più a rischio?
I fattori predisponenti sono molteplici:
- Il fumo di sigaretta;
- una dieta ad elevata assunzione di carne rossa, cibi affumicati e sotto sale e povera in frutta e verdure;
- l’infezione da Helicobacter Pylori, il quale induce una serie di alterazioni istologiche che precedono lo sviluppo del carcinoma gastrico quali la gastrite cronica, metaplasia intestinale, atrofia e displasia.
Il tumore allo stomaco si può prevenire?
La prevenzione primaria del tumore gastrico potrebbe essere potenzialmente possibile attraverso la dieta, incoraggiando le popolazioni ad alto rischio a diminuire il consumo di carni affumicate, insaccati ed alimenti conservati con sale e ad aumentare il consumo di frutta e verdura. La prevenzione può anche essere fatta attraverso l’eradicazione dell’infezione da H.pylori, in particolare nell’infanzia e nell’adolescenza.
Ci sono regioni a maggiore incidenza di casi?
La sede più frequente di insorgenza è la regione antro-pilorica (distale) anche se negli ultimi anni in Europa e in U.S.A. è riportata una elevata incidenza di neoplasie cardiali e della giunzione esofago-gastrica (prossimali).
Caratteristiche istologiche
Tumore allo stomaco: quanti tipi esistono?
Macroscopicamente il carcinoma gastrico è distinto in forme iniziali (Early Gastric Cancer) e forme avanzate.
Forme iniziali:
- PenA: maggiore frequenza di metastasi linfonodali rispetto agli altri EGC e basso tasso di sopravvivenza;
- PenB: confinate alla mucosa e sottomucosa;
Forme avanzate, classificate da Borrmann come:
- polipoidi (tipo I);
- esofitiche/fungiformi (tipo II);
- ulcerate (tipo III);
- diffusamente infiltranti (tipo IV).
Microscopicamente è caratterizzato da un’ampia eterogeneità intratumorale e non è raro osservare casi in cui coesistono aspetti citologici ed architetturali differenti.
Quali sono i tipi istologici più frequenti?
La classificazione WHO prevede 4 tipi istologici più frequenti:
- carcinoma tubulare;
- papillare;
- mucinoso;
- a cellule ad anello con castone;
- alcune varianti rare (carcinoma epatoide, carcinoma con stroma linfoide, corioncarcinoma, carcinoma adenosquamoso, squamoso, indifferenziato ed a piccole cellule).
La classificazione di Lauren ha trovato grande diffusione ed applicazione, soprattutto per la sua semplicità. Essa distingue due tipi principali di carcinoma, quello di “tipo intestinale” e quello “diffuso”. Le neoplasie che presentano entrambi gli aspetti vengono classificate come “tipo misto”.
Diffusione
Quali organi colpisce il carcinoma gastrico?
Il carcinoma gastrico diffonde prevalentemente:
- agli organi contigui: (quali pancreas, duodeno, esofago, colon trasverso, peritoneo);
- per via linfatica: con invasione di stazioni linfonodali regionali ed extraregionali ovvero anche a distanza del sito tumorale;
- per via ematica: più frequentemente al fegato, ai polmoni.
Quadro clinico
Quali sono i principali sintomi del tumore allo stomaco?
I sintomi sono vaghi ed aspecifici, di solito sottovalutati per molto tempo o trattati come “gastrite” o ulcera benigna.
I più comuni sono:
- perdita di peso;
- dolenzia epigastrica;
- nausea;
- anoressia;
- anemia;
- disfagia (per i tumori cardiali e della giunzione esofago-gastrica);
- sazietà precoce;
- sarcofobia (repulsione per la carne).
I sintomi possono essere assenti fino a che il tumore non raggiunge dimensioni tali da dare stenosi od emorragie.
Manifestazioni cliniche di estensione metastatica sono:
- la comparsa di dolori addominali;
- l’aumento di volume del fegato;
- la comparsa di ascite;
- l’ittero;
- i linfonodi palpabili (quelli della regione sopraclaveare sinistra vengono identificati come il “segno di Troiser”)
Talvolta, la malattia metastatica si estende a livello peritoneale con interessamento delle ovaie (tumore di Krukenberg) e successiva diffusione alla regione pre-rettale e retro-vescicale.
Diagnosi e stadiazione
Come si diagnostica il tumore dello stomaco?
Il gold standard diagnostico per il tumore dello stomaco è rappresentato senza dubbio dalla Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) che consente, oltre ad una visione diretta del viscere, anche la possibilità di effettuare prelievi bioptici necessari per porre diagnosi istologica.
Ulteriori metodiche di diagnostica per immagini per la diagnosi, lo staging ed il follow-up del carcinoma gastrico sono:
- l’Rx del tubo digerente (sempre meno utilizzato dopo la diffusione dell’endoscopia);
- l’ecografia con o senza mezzo di contrasto;
- la TC torace ed addome con mezzo di contrasto;
- l’ecoendoscopia;
- la laparoscopia diagnostica.
Il tumore dello stomaco è visibile agli esami del sangue?
I biomarcatori circolanti (CEA, CA 19.9, AFP, BHCG) svolgono un ruolo marginale nella diagnosi del carcinoma dello stomaco, mentre sono piu attendibili nel monitoraggio post-operatorio (follow-up) fornendo un’informazione più precisa sul decorso clinico o più tempestiva sulla presenza di una recidiva, in modo da selezionare il trattamento terapeutico ottimale.
Quali sono le linee guida della diagnosi?
Il tumore è studiato usando la classificazione TNM che descrive:
- l’estensione anatomica della lesione (T) al momento della diagnosi e dopo terapia;
- la presenza od assenza di linfonodi loco-regionali (N) e di metastasi (M).

Terapia medica
Si può curare il tumore dello stomaco?
Si parla di:
- chemioterapia neoadiuvante o preoperatoria quando precede la chirurgia;
- chemioterapia adiuvante se viene eseguita dopo l’intervento chirurgico (ha lo scopo di ridurre il rischio di recidiva locale o la comparsa di metastasi a distanza)
Le associazioni chemioterapiche comprendono sali di platino (cisplatino o oxaliplatino), fluoropirimidine (fluorouracile, capecitabina) e antracicline (epiadriamicina) che, quando utilizzate preoperatoriamente, sono in grado di ottenere una risposta patologica parziale o completa sul tumore primitivo e sui linfonodi aumentando le possibilità di ottenere la radicalità chirurgica.
E’ necessario ricorrere alla chemioterapia?
Quando la malattia è avanzata sia a livello loco regionale sia a distanza (fegato, polmoni, linfonodi, peritoneo, osso) la chemioterapia rappresenta l’unica arma terapeutica in grado di ottenere il controllo della malattia. Tra le nuove molecole attive nel carcinoma gastrico avanzato ci sono i farmaci antiangiogenetici. I chemioterapici sono somministrati tipicamente per via endovenosa e in alcuni casi in compresse e la loro somministrazione avviene attraverso cicli di trattamento a cadenza variabile.
Terapia chirurgica
E’ possibile ricorrere alla chirurgia?
Gli interventi che si possono realizzare nella chirurgia del cancro gastrico vengono distinti in:
- interventi di exeresi, con intendimento di radicalità in senso oncologico;
- interventi palliativi, che potranno essere di exeresi o di derivazione.
In alcuni casi per altro, anche la palliazione non è realizzabile e l’intervento si limita alla sola esplorazione. In caso di metastasi singole o di infiltrazione di singoli organi contigui può essere valutata l’opportunità di una metastasectomia e di una resezione della porzione di organo infiltrato (fegato, colon traverso, mesocolon, pancreas, milza, parete addominale anteriore).
Quanti tipi di interventi chirurgici esistono?
In base alla localizzazione del tumore distinguiamo 3 tipi di interventi chirurgici:
- resezione polare superiore o inferiore;
- gastrectomia subtotale;
- gastrectomia totale associata a linfoadenectomia D1, D2 o D3
Cos’è la linfoadenectomia?
Questo intervento consiste nell’asportazione dei tessuti linfatici retro e perigastrici localizzati lungo i tronchi vascolari maggiori e nelle zone di confine come duodeno, pancreas, ilo epatico e mesentere superiore.
Può essere ulteriormente ampliato con la exeresi di altri visceri contigui che fossero eventualmente interessati dalla neoplasia (gastrectomia totale allargata) e comprende la resezione en-bloc di:
- stomaco;
- 2 cm circa di esofago e duodeno;
- corpo e coda del pancreas;
- milza con epiploon.
In questo caso la linfoadenectomia viene condotta fino alle catena epatica, gastroduodenale, para-aortica e renale.
In Giappone viene sempre praticata una linfoadenectomia allargata D3 e così anche per l’EGC, dove i linfonodi N3, N4 sono positivi nel 1%.
Nel resto del mondo non esiste attualmente un orientamento comune.
Infatti le precise indicazioni alla linfoadenectomia, la morbilità e mortalità post-operatoria legate a tale manovra e la sua reale efficacia in termini prognostici non sono completamente codificate.
Quali tecniche sfrutta la linfoadenectomia?
L’intervento è completato ripristinando la continuità intestinale mediante molteplici tecniche fra le quali le piu’ utilizzate sono:
- la ricostruzione gastro-digiunale secondo Billroth II con ansa “a omega”;
- la ricostruzione gastro-digiunale secondo Roux con pie’ d’ansa a “Y” (utile per evitare complicanze tipiche della Billroth II quali la gastrite biliare da reflusso duodeno-gastrico)
L’approccio chirurgico puo’ essere per via tradizionale (o laparotomico) o per via laparoscopica ovvero mininvasiva.
La laparotomia funziona?
L’utilizzo della laparoscopia nel carcinoma gastrico è tecnica consolidata per quel che riguarda la stadiazione intra-operatoria essendo infatti possibile evidenziare l’estensione loco-regionale della neoplasia e l’eventuale presenza di metastasi a distanza o di carcinosi peritoneale. A seconda del reperto intraoperatorio si deciderà se proseguire per via laparotomica con una resezione curativa o semplicemente con una palliazione.
La laparoscopia funziona?
Per quel che riguarda invece la laparoscopia nel trattamento del carcinoma gastrico, il mondo scientifico è all’inizio dell’ esperienza e non ha ancora trovato uno spazio consolidato. Sono stati pubblicati numerosi studi che dimostrano la fattibilità tecnica, ma per quel che riguarda i risultati si è ancora lontani da conclusioni definitive.
Come controllare il tumore dello stomaco avanzato?
Un miglioramento nel controllo regionale della neoplasia gastrica localmente avanzata, può essere conseguito mediante l’utilizzo della chemioipertermia intraperitoneale:
- una volta espletata la exeresi di una eteroplasia gastrica infiltrante la sierosa;
- in presenza di una carcinosi peri-gastrica;
- nel caso di una citologia peritoneale positiva, accertata durante la exeresi chirurgica della neoplasia o in corso di una laparoscopia di staging pre-operatoria.
Quali farmaci si usano per la chemioipertermia?
I farmaci comunemente utilizzati per la chemioipertermia sono rappresentati dal Cisplatino (25 mg/l/mq) e dalla Mitomicina C (3,3 mg/l/mq) a temperatura di circa 42 gradi per 60 minuti.
Quali complicanze possono sorgere durante l’intervento?
Le complicanze dell’intervento chirurgico possono essere molteplici: intraoperatorie, postoperatorie precoci e tardive.
Tra le complicanze intraoperatorie troviamo:
- contusione o rottura di milza o fegato;
- lesioni vascolari;
- lesione delle vie biliari o del mesolon traverso
Tra le complicanze postoperatorie precoci invece:
- la fistola e la deiscenza anastomotica;
- la stenosi anastomotica;
- le emorragie;
- la pancreatite;
- la formazione di ematomi;
- empiemi o ascessi;
- l’ischemia;
- la necrosi delle anse peduncolizzate
Tra le tardive figurano:
- dumping sindrome;
- la diarrea incoercibile;
- l’ileo meccanico;
- sindrome dell’ansa afferente;
- gastrite o esofagite da reflusso biliare;
- sindrome da gastrectomia totale con malassorbimento di VIT B12, acido folico, VIT D e ferro e conseguente anemia, calo ponderale, osteomalacia ed osteoporosi.
Bibliografia
- Ilic M, Ilic I. Epidemiology of stomach cancer. World J Gastroenterol. 2022 Mar 28;28(12):1187-1203. doi: 10.3748/wjg.v28.i12.1187. PMID: 35431510; PMCID: PMC8968487.
- Poorolajal J, Moradi L, Mohammadi Y, Cheraghi Z, Gohari-Ensaf F. Risk factors for stomach cancer: a systematic review and meta-analysis. Epidemiol Health. 2020;42:e2020004. doi: 10.4178/epih.e2020004. Epub 2020 Feb 2. PMID: 32023777; PMCID: PMC7056944.
- Joshi SS, Badgwell BD. Current treatment and recent progress in gastric cancer. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):264-279. doi: 10.3322/caac.21657. Epub 2021 Feb 16. PMID: 33592120; PMCID: PMC9927927.
- Wang Y, Zhang L, Yang Y, Lu S, Chen H. Progress of Gastric Cancer Surgery in the era of Precision Medicine. Int J Biol Sci. 2021 Mar 2;17(4):1041-1049. doi: 10.7150/ijbs.56735. PMID: 33867827; PMCID: PMC8040314.


