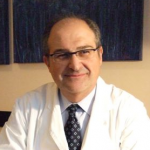Che cos'è l'acufene?
L'acufene può essere definito come la percezione di un rumore nell'orecchio o in entrambi o in testa avvertibile soprattutto la sera quando ci corichiamo e in qualche caso anche di giorno allorché la sua intensità sovrasta quella dell'ambiente in cui comunemente viviamo.
L'acufene è una malattia o un sintomo?
Deve essere considerato non come una "malattia", ma come un sintomo, un segnale di una situazione di "stress" che sta interessando il nostro organismo ovverosia è un campanello di allarme.
Pertanto non dovrebbe avere in sé un significato negativo, ma purtroppo, essendo per lo più fastidioso per il soggetto che lo percepisce, può diventare a volte una "compagnia" davvero insopportabile.
Acufene soggettivo o cronico?
Gli acufeni che invece abitualmente ci affliggono sono quelli soggettivi: sono molto frequenti interessando dal 35 % al 45 % della popolazione adulta e fino al 90 % dei pazienti portatori di ipoacusia, ma sono nel 99 % dei casi saltuari.
Solo l'1% della popolazione soffre invece di acufeni persistenti o cronici, ma di questo gruppo ristretto quasi tutti ( il 90 % ) non riescono a sopportarli vivendoli come un fattore irritante e non come un messaggio di allarme che ci avverte che qualcosa non funziona o a livello del sistema uditivo, o a livello del cervello (sede dell'elaborazione cosciente del suono ) o a livello dei muscoli e della colonna vertebrale (sede del movimento), o a livello del nostro metabolismo e del sistema nutrizionale che, se alterati, possono creare segnali bioelettrici anomali che, interferendo con i recettori uditivi , sono in grado di scatenare l'acufene.
Quali sono le cause dell'acufene?
La genesi degli acufeni e la loro cura, è pertanto molto complessa poiché interessa un sistema come quello uditivo estremamente sfaccettato, sia a livello della sua struttura di ricezione dei suoni, sia a livello dei suoi intimi rapporti col sistema motorio, con la sfera cognitiva e con la componente emotivo-affettiva dell'individuo.
Gli acufeni sono quindi il risultato della disfunzione di una o più di queste componenti , ma , indipendentemente dalla sede iniziale della disfunzione, secondo Shulman, si assiste sempre ed inevitabilmente all'attivazione della cosiddetta via finale comune, rappresentata da alcune aree cerebrali: lobo temporale medio, amigdala, ippocampo; è in queste aree che i segnali uditivi anomali si memorizzano dando luogo alla percezione sonora aberrante cronica ovvero all'acufene persistente.
Diagnosi
Il modello di acufene come segnale d'allarme, come reazione ad una situazione di stress che sta interferendo col nostro organismo, ed il concetto di via ultima comune sono i presupposti sui quali ci si basa per strutturare la diagnosi e la terapia degli acufeni.
Come si svolge una diagnosi di acufene?
- la fase acuta o d'allarme;
- la fase di resistenza dove il soggetto cerca di resistere all'acufene;
- la fase esaustiva o d'esaurimento (dove prevale la via finale comune e la memorizzazione definitiva dell'acufene).
Quali sono i principali esami diagnostici?
Importanti anche le valutazioni elettroencefalografiche e uno screening ematochimico che abbracci anche le componenti ormonali e lo stress ossidativo del soggetto.
E' possibile curare acufene?
Cosa fare se l'acufene è cronico?
Quali sono i farmaci contro acufene cronico?
In conclusione l'acufene solo in qualche raro caso si può eliminare, ma, anche se nella maggior parte dei casi ciò non è possibile, si può però cercare di attenuarlo, con le terapie sopra riportate, smussandone gli aspetti motori, cognitivi e affettivi che lo alimentano.
Bibliografia
- Int Tinnitus J. 2003;9(2):104-8. The role of free radicals and plasmatic antioxidant in Ménière's syndrome. Raponi G e altri
- Depress Anxiety. 2003;17(2):101-6. Serotonergic modulation of the balance system in panic disorder: an open study. Perna G, Raponi G, Bellodi L. e altri
In collaborazione con Anxiety Disorder Clinical and Research Unit, Vita-Salute University, Istituto Scientifico HS Raffaele, Milan, Italy. - Curr Opinion Neurology 2007 Feb;20(1):40-6 Epidemiology of vertigo
Neuhauser HK. Department of Epidemiology , Robert Koch Institute , Berlin , Germany - Cochrane database Syst. Rev. 2011 Feb 16;2:CDOO5397 Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction Hiller SL , Mc Donnel M. Adelaide ( Australia).
- Advance in Otorhinolaryngol 2011 ; 70 : 130-4 Epub 2011 Feb 24 Genetic of vestibulopathies Jen JC – Departement of Neurology UCLA School Medicine Los Angeles Cal. USA.
- Braz. J Otorhinolaryngol 2008 jul-Aug ; 74 (4) : 606-12 Migraine associated with auditory-vestibular dysfunction Cal R , Bahamad Jr F Otology Department Massachusetts USA.
- Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Oct;12(5):413-7. Mechanisms of tinnitus generation. Bauer CA. Department of Surgery, Division of Otolaryngology, Southern Illinois University School of Medicine, Springfield, IL 62792-9662, USA.
- Otol Neurotol. 2011 Feb 25 Administration of the Combination Clonazepam-Deanxit as Treatment for Tinnitus. Meeus O, De Ridder D, Van de Heyning P. Int Tinnitus J. 2009;15(1):5-50.
- Final common pathway for tinnitus: theoretical and clinical implications of neuroanatomical substrates. Shulman A, Goldstein B, Strashun AM.
Martha Entenmann Tinnitus Research Center, Forest Hills, New York, USA. - The Tinnitus Research Initiative (TRI) database: a new approach for delineation of tinnitus subtypes and generation of predictors for treatment outcome.
Landgrebe M, Zeman F, Koller M, Eberl Y, Mohr M, Reiter J, Staudinger S, Hajak G, Langguth B. BMC Med Inform Decis Mak. 2010 Aug 3;10:42. - Mazurek B, Hesse G, Dobel C, Kratzsch V, Lahmann C, Sattel H; Guideline group. Chronic Tinnitus. Dtsch Arztebl Int. 2022 Apr 1;119(13):219-225. doi: 10.3238/arztebl.m2022.0135. PMID: 35197187; PMCID: PMC9342131.
- Czornik M, Malekshahi A, Mahmoud W, Wolpert S, Birbaumer N. Psychophysiological treatment of chronic tinnitus: A review. Clin Psychol Psychother. 2022 Jul;29(4):1236-1253. doi: 10.1002/cpp.2708. Epub 2022 Jan 13. PMID: 34994043.
- Chen S, Du M, Wang Y, Li Y, Tong B, Qiu J, Wu F, Liu Y. State of the art: non-invasive electrical stimulation for the treatment of chronic tinnitus. Ther Adv Chronic Dis. 2023 Jan 18;14:20406223221148061. doi: 10.1177/20406223221148061. PMID: 36860934; PMCID: PMC9969452.