Calcolosi Biliare
Il caso della sig.ra paziente Y
La sig.ra Y ha 42 anni e fa risalire l'inizio della sintomatologia a ben prima della gravidanza, circa 3 anni fa, quando, dopo pranzo, ha avuto un episodio di dolore intenso in epigastrio, irradiato sotto l'arcata costale destra e dietro fino all'apice della scapola, accompagnato da nausea e vomito. Il dolore è durato circa 2 ore, e si è risolto solo dopo somministrazione di Buscopan intramuscolo.
Al quinto mese di gravidanza, altro episodio del tutto analogo,anche in questo caso regredito dopo l'assunzione di un antispastico.
Dopo il parto, gli episodi di dolore si sono ripetuti abbastanza regolarmente, circa uno al mese, e si sono verificati spesso di notte.
Calcolosi Biliare: che cos’è?
Il quadro clinico presentato è piuttosto tipico della calcolosi biliare, cioè della presenza di calcoli nella colecisti e/o nelle vie biliari, i condotti che portano la bile dal fegato fino all'intestino. La bile è essenziale per l'assorbimento degli acidi grassi e tra un pasto e l'altro, anziché finire sprecata, viene immagazzinata nella colecisti, una specie di sacchetto posto al di sotto del fegato e ad esso legato. Qui la sua composizione viene modificata. Se questa rielaborazione non si svolge in maniera corretta (proprio per un difetto primario della colecisti), la bile può divenire "soprassatura", cioè i componenti al suo interno non sono più in soluzione ma tendono a precipitare, come quando mettiamo troppo zucchero nel caffè, e formare un residuo granulare semisolido. Successivamente, questa "fanghiglia" biliare (noi chirurghi la chiamiamo "sludge", ma è lo stesso) tende a consolidarsi in calcoli, cioè "pietre" più o meno dure (a seconda della composizione).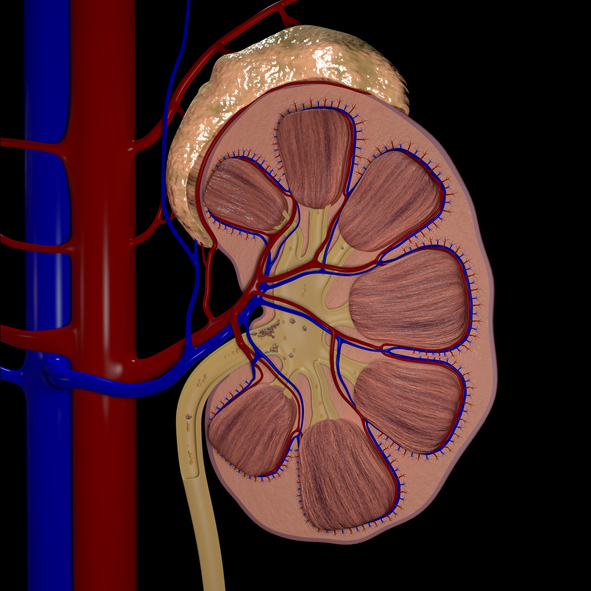
Sintomi
Quali sono i sintomi dei calcoli biliari?
Il destino di questi calcoli è vario. Spesso restano asintomatici per tutta la vita, e vengono scoperti nel corso di esami diagnostici di controllo o eseguiti per altri motivi.
In altri casi, invece, danno segno di sé.
Il primo e più comune segno della presenza di calcoli nella colecisti è la cosiddetta colica biliare: un dolore intenso, improvviso, trafittivo, che parte dall'ipocondrio destro e si irradia posteriormente fino all'apice della scapola, insorge dopo il pasto e dura qualche ora.
Nel 10% dei casi circa, la calcolosi della colecisti dà segno di sé con una complicanza, cioè con una colecistite acuta, una pancreatite o un ittero.
Cos’è la colecistite acuta?
La colecistite acuta è una infiammazione della colecisti: alla colica biliare si associano febbre e segni di peritonite, che all'inizio è localizzata, ma può diffondersi con il progredire dell'infezione.
Cos’è la pancreatite acuta?
La pancreatite acuta è una infiammazione del pancreas dovuta (spesso ma non sempre) alla presenza di piccoli calcoli che dalla colecisti scendono lungo il coledoco e vanno ad ostruire il dotto pancreatico, causando l'accumulo del secreto del pancreas e l'attivazione dei suoi enzimi.
Cos’è l’ittero?
L'ittero è dovuto all'ostruzione del coledoco da parte di calcoli provenienti dalla colecisti. In tale situazione la bilirubina si accumula nel fegato e passa in circolo nel sangue, andando a fissarsi soprattutto nella cute e nelle sclere.
Diagnosi
Come si diagnostica la calcolosi della colecisti?
La diagnosi di calcolosi della colecisti è piuttosto semplice: oltre ad una storia clinica significativa basterebbe l'ecografia epatica.
Gli esami ematici sono invece indispensabile per escludere che ci sia in atto una ostruzione biliare dovuta ad una calcolosi del coledoco (che peraltro sarebbe già sospettabile sulla base della presenza di dilatazione delle vie biliari a monte dell'eventuale ostruzione). In presenza di una calcolosi del coledoco, prima di rimuovere la colecisti è opportuno bonificare il coledoco stesso. Questo avviene mediante una procedura endoscopica chiamata colangiopancreatografia retrograda (CPRE)
Cos’è la CPRE?
Con un endoscopio si raggiunge dalla bocca lo sbocco del coledoco nell'intestino e da lì si inseriscono, sotto guida radiologica, cateteri, pinze e quant'altro possa servire per la rimozione dei calcoli. La CPRE però è da considerare un vero e proprio intervento chirurgico, che ha i suoi rischi. Per questo motivo se ne pone indicazione solo se siamo certi della presenza di calcoli nella via biliare. La certezza in questo senso (o meglio, un forte sospetto) è data dall'esecuzione di una colangiopancreatografia in risonanza magnetica (CPRM) che, con metodica non invasiva, ci permette di verificare lo stato delle vie biliari e pancreatiche.
Cure e Trattamenti
Quali terapie ci sono per la colecisti sintomatica?
La terapia della colecisti sintomatica è solo chirurgica.
La cosiddetta litolisi chimica, mediante l'assunzione di sali biliari, può essere indicata solo in presenza di sabbia biliare senza calcoli o micro calcoli di colesterolo senza calcio o nel paziente che non può essere sottoposto ad intervento chirurgico per patologie associate gravi. Comunque, la terapia con sali biliari, pur se efficace (e non sempre lo è) comporta alla sua sospensione una elevatissima probabilità di recidiva.
Come tratto i calcoli asintomatici?
In presenza di calcoli non sintomatici il discorso è complesso. In teoria, e solo in teoria, la scoperta casuale di calcoli della colecisti non associati a sintomi specifici non è di per sé indicazione all'intervento chirurgico. Ma sappiamo bene come ogni calcolosi ha un rischio di diventare sintomatica (circa il 10% ogni anno, il che significa che entro 10 anni virtualmente ogni calcolosi inizialmente asintomatica dà segno di sé) a seguito di una "semplice" colica biliare o altra complicanza (colecistite, ittero, pancreatite). Per questo motivo, la scelta se operare o no dipende dalla valutazione caso per caso e dal dialogo tra chirurgo e paziente.
Qual è l’intervento chirurgico per i calcoli della colecisti?
La terapia chirurgica della colelitiasi è la colecistectomia, cioè l'asportazione della colecisti. Non ha senso, infatti, asportare solo i calcoli in quanto è l'organo stesso la causa della patologia: i calcoli sono una conseguenza di una anomalia della colecisti.
Come si effettua la colecistectomia?
Oggigiorno la colecistectomia viene eseguita quasi sempre per via laparoscopica, cioè con 3-4 piccoli buchi sulla superficie dell'addome (recentemente è stata introdotta anche una tecnica con un solo accesso). Come al solito, si entra con una telecamera e con due o tre strumenti che ci consentono di chiudere l'arteria cistica e il dotto cistico, staccare la colecisti dal fegato e asportarla.
La colecistectomia è rischiosa?
C'è sempre, come in ogni intervento laparoscopico, il rischio di dover convertire in laparotomia (cioè nel classico accesso con una più o meno ampia incisione sottocostale). Nella colelitiasi sintomatica semplice tale rischio è piuttosto basso (dell'ordine del 2-3%), ma sale fino al 20-25% se si opera il paziente in acuto nel corso di una colecistite.
Il rischio di complicanze è basso.
La complicanza più temibile è la lesione iatrogena del coledoco (circa 0,01-0,1% dei casi a seconda dell'esperienza dell'operatore), che spesso può risolversi con un approccio endoscopico ma talvolta richiede un vero e proprio intervento chirurgico ed ha un decorso spesso problematico.
Sono pressoché assenti le complicanze parietali (ad esempio gli ascessi sottocutanei e i laparoceli). L'emorragia è una complicanza rara ma sempre possibile. Di solito avviene intraoperatoriamente (e spesso richiede una conversione laparotomica), talvolta può invece avvenire nel periodo postoperatorio e, per il suo controllo, è necessario un reintervento che quasi sempre è laparotomico. Anche le lesioni dell'intestino sono evenienze possibili, che possono essere riconosciute nel corso dell'intervento e trattate per via laparoscopica o con una conversione laparotomia. Si può dire che le complicanze della colecistectomia laparoscopica sono potenzialmente degli eventi drammatici, ma fortunatamente si tratta di situazioni piuttosto rare.
Colecistectomia: quanto dura l’intervento?
Nella grandissima maggioranza dei casi (circa il 99%) l'intervento e il periodo postoperatorio si svolgono nel migliore dei modi e senza complicanze di rilievo. Dopo poche ore dall'intervento, che dura generalmente 40 minuti, il paziente ricomincia ad alimentarsi e viene tenuto per 15 giorni con una dieta povera di grassi, per consentire l'assestamento del fegato e delle vie biliari dopo l'asportazione della colecisti; successivamente riprende ad alimentarsi normalmente. Il rientro al lavoro può avvenire non appena il paziente stesso si sente in grado di svolgere le comuni attività, di solito entro 3-7 giorni.
Bibliografia
- Cianci P, Restini E. Management of cholelithiasis with choledocholithiasis: Endoscopic and surgical approaches. World J Gastroenterol. 2021 Jul 28;27(28):4536-4554. doi: 10.3748/wjg.v27.i28.4536. PMID: 34366622; PMCID: PMC8326257.
- Troncone E, Mossa M, De Vico P, Monteleone G, Del Vecchio Blanco G. Difficult Biliary Stones: A Comprehensive Review of New and Old Lithotripsy Techniques. Medicina (Kaunas). 2022 Jan 13;58(1):120. doi: 10.3390/medicina58010120. PMID: 35056428; PMCID: PMC8779004.
- Hjaltadottir K, Haraldsdottir KH, Moller PH. [Gallstones - review]. Laeknabladid. 2020 Oct;106(10):464-472. Icelandic. doi: 10.17992/lbl.2020.10.602. PMID: 32991309.


